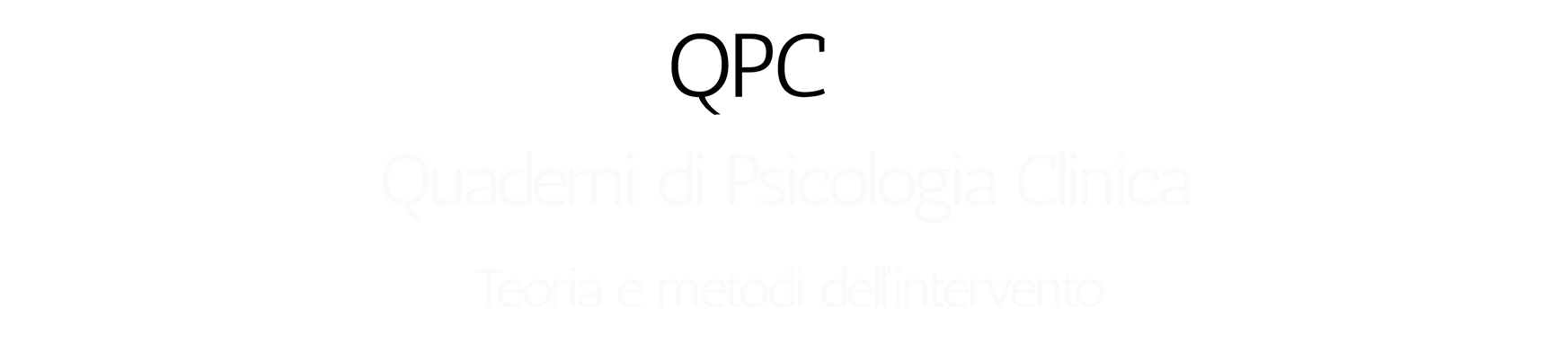Amicizia come paradigma della socialità
Contenuto principale dell'articolo
Abstract
Nel postmoderno il legame sociale è più debole e abbiamo rinunciato all’idea di progresso. La reciprocità, sinora attribuita alle istituzioni primarie e alle società fondate sulla parentela, oggi è più vicina a noi. Per sconfermare l’allarme sociale, è divenuta l’ingrediente base del vivere umano. Non la cerchiamo più nei macrosistemi e in regole universali, ma nella quotidianità e in specifiche realtà, dotate di loro sistemi di cooperazione. In questo lavoro si propone in proposito una specifica tesi, dove si ancora, seppure con prudenza, la dinamica culturale a quella storica e relazionale, e le fonti della reciprocità vengono rintracciate sia nella parentela che nell’amicizia. L’amicizia viene proposta come una relazione personale e prescelta, mantenuta volontariamente da soggetti che si considerano distinti ed eguali e che instaurano tra loro una reciprocità simmetrica, caratterizzata da una dichiarazione idealizzata di non strumentalità. Viene proposto come questo paradigma relazionale abbia costituito il riferimento ideale per le istituzioni occidentali e per le soggettività da esse sviluppate, uniformando con i suoi caratteri la struttura delle società e le forme del sapere. La socialità fine a se stessa proposta dal paradigma dell’amicizia, lungi dal costituire un fattore di inibizione all’agire sociale, ne rappresenta invece un efficace potenziamento. Infatti l’amicizia necessita di essere estrinsecata in azioni di reciproca e manifesta benevolenza.
Dettagli dell'articolo
Sezione
Come citare
Riferimenti bibliografici
De Martino, E. (1948). Il mondo magico: Prolegomeni a una storia del magismo [The wizarding world: Prolegomena to a history of magism]. Einaudi: Torino.
De Martino, E. (1958). Morte e pianto rituale nel mondo antico: Dal lamento pagano al pianto di Maria [Death and ritual weeping in the ancient world: from pagan lament to Mary’s weeping]. Milano: Bollati Boringhieri.
Eco, U. (2009). Vertigine della lista [Vertigo of the list]. Milano: Bompiani.
Eibl-Eibesfeldt, I., (1996). I fondamenti dell’Etologia [The foundations of Ethology] (A. Sassi, & F. Scapini, Trans.). Milano: Adelphi (Original work published 1967).
Elias, N. (2011). La solitudine del morente [The solitude of the dying] (M. Keller, Trans.). Bologna: Il Mulino (Original work published 1982).
Geerz, C. (1973). The interpretation of cultures. New York: Basic Books.
Goffman, E. (1997). La vita quotidiana come rappresentazione [The Presentation of Self in Everyday Life] (M. Ciacci, Trans.). Bologna: Il Mulino (Original work published 1956). Bologna: Il Mulino.
Hamilton, WD. (1963). The evolution of altruistic behavior. American Naturalist, 97(869), 354-356. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/2458473?origin=JSTOR-pdf
Hamilton, W.D. (1964). The genetical evolution of social behavior. I, II. Journal of Theoretical Biology, 7(1), 1.16. Retrieved from https://doi.org/10.1016/0022-5193(64)90038-4
Lombardi Vallauri, L. (Ed.). (1978). L’amicizia: Il “Laelius” di Cicerone e altri testi di Cicerone, Aristotele, Epicuro, Seneca, Epitteto [Friendship: The “Laelius” by Cicero and other texts by Cicero, Aristotle, Epicurus, Seneca, Epittetus]. Paravia: Torino.
Lorenz, K. (1974). Il cosiddetto male [The so-called evil] (E. Bolla, Trans.). Milano: Garzanti (Original work published 1963).
Lyotard, J.F. (1981). La condizione postmoderna: Rapporto sul sapere [The postmodern condition: Knowledge report] (C. Formenti, Trans.). Milano: Feltrinelli (Original work published 1979).
Mangini, C. (1960). Stendalì: Suonano ancora [Stendalì: Thei still play] (Documentario). Retreived from https://www.youtube.com/watch?v=vziV5npthaI
Mauss, M. (1938). Une catégorie de l’esprit humain: La notion de personne celle de “moi” [A category of the human mind: The notion of person]. Journal of the Royal Anthropological Institute, 68, 263-281. doi: 10.2307/2844128
Padiglione, V. (1978). L’amicizia: Per una storia di un bisogno estraniato [Friendship: For a story of estranged need]. Savelli: Roma.
Parisi, D. (1982). Sociobiologia e relazioni affettive [Sociobiology and affective relationships]. In V. Parisi, & F. Robustelli (Eds.), Il dibattito sulla sociobiologia. Atti del I° Seminario sulla Sociobiologia (Roma, 20-21 aprile 1979) (pp. 29-38). Roma: Istituto di Psicologia-CNR.
Pitkin, D.S. (1992). La casa che Giacomo costruì [The house that Giacomo built] (G. Mecchia, Trans.). Bari: Dedalo (Original work published 1985).
Tiger, L. (1969). Men in groups. New York: Random House.
Trivers, R. (1971). The Evolution of Reciprocal Altruism. The Quarterly Review of Biology, 46(1), 35-57. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/2822435
Wittgenstein, L. (2009). Ricerche filosofiche [Philosophical researches] (M. Trinchero, Ed. & Trans.). Torino: Einaudi (Original work published 1953).